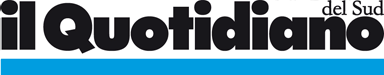9 minuti per la lettura
A far scatenare la scintilla della rabbia sociale possono essere episodi di corruzione che diano la percezione che non si stia agendo nell’interesse della gente
Assistiamo spesso, in quasi tutte le società, a episodi nei quali esplode la rabbia sociale, un sentimento collettivo diffuso di frustrazione, scontento, indignazione all’interno di una comunità più o meno larga. La rabbia sociale può essere un processo complesso e multiforme, con molteplici cause interconnesse che variano da contesto a contesto: la sua comprensione richiede l’analisi di fattori sociali, economici e politici specifici che contribuiscono alle dinamiche di un dato contesto sociale. Spesso, insomma, è una serie di fattori sovrapposti che genera un processo di rabbia sociale, come accade per esempio nella percezione di disuguaglianze economiche e sociali significative tra diverse fasce della popolazione; quando le persone ritengono che esistano disparità ingiuste nell’accesso alle risorse, alle opportunità e ai benefici sociali ed economici, possono sviluppare sentimenti di frustrazione e indignazione.
Così come in presenza di ingiustizie sistemiche, discriminazioni razziali, di genere o di altro tipo. Queste ingiustizie possono essere evidenti a livello istituzionale o strutturale, portando le persone a sentirsi tradite o addirittura oppresse da un sistema che dovrebbe garantire giustizia ed equità. Ma a far scatenare la scintilla della rabbia possono essere episodi di corruzione, che si legano alla percezione che i leader politici non stiano agendo nell’interesse della popolazione; così come periodi di recessione economica, disoccupazione elevata o altre sfide economiche possono aumentare la rabbia sociale poiché le persone possono sentirsi abbandonate o tradite dalle istituzioni che dovrebbero proteggere il loro benessere.
Inoltre, anche la percezione di esclusione dai processi decisionali o dalla partecipazione politica può sviluppare rabbia sociale. La percezione di un sistema che non ascolta o risponde alle preoccupazioni della popolazione può alimentare il malcontento, così come abusi di potere, violazioni dei diritti umani o altri incidenti traumatici, possono a loro volta scatenare rabbia sociale, specialmente se questi eventi colpiscono un ampio segmento della società.
I sociologi hanno sviluppati molte teorie per provare ad interpretare i fenomeni di rabbia sociale. La teoria del conflitto, per esempio, sviluppata da sociologi come Karl Marx, si concentra sulle disuguaglianze di potere e risorse nella società. Secondo questa teoria, la rabbia sociale può derivare da conflitti tra gruppi sociali che competono per risorse limitate. La lotta per il potere e l’accesso alle risorse può portare a tensioni e manifestazioni di rabbia sociale. La teoria dell’interazionismo simbolico, invece, promossa da sociologi come Herbert Blumer, si concentra sul significato simbolico attribuito alle interazioni sociali. Nell’ambito della rabbia sociale, gli interazionisti simbolici esaminano come le persone attribuiscano significato agli eventi, alle ingiustizie e alle disuguaglianze, influenzando la percezione collettiva di oppressione e la risposta emotiva.
Alcuni sociologi analizzano invece la rabbia sociale attraverso il prisma delle strutture sociali, osservando come le istituzioni e le norme sociali influenzino le esperienze e le opportunità delle persone. Quando le strutture sociali perpetuano disuguaglianze e ingiustizie, la rabbia sociale può emergere come risposta alle condizioni percepite come oppressive. Per quanto concerne la teoria della mobilitazione delle risorse, essa esamina come le persone si organizzano e mobilitano risorse, inclusi tempo, denaro e sostegno sociale, per raggiungere obiettivi comuni.
Nell’ambito della rabbia sociale, la mobilitazione delle risorse può essere fondamentale per la creazione di movimenti e proteste che cercano di affrontare ingiustizie e disuguaglianze. Infine, la teoria dell’identità sociale, che esplora come le persone sviluppano un senso di appartenenza e identità attraverso l’affiliazione a gruppi sociali. La rabbia sociale può emergere quando le persone si identificano con un gruppo che percepisce ingiustizie o discriminazioni e si mobilitano in risposta a tali percezioni. La rabbia sociale è quindi intimamente legata a fenomeni di aggressività, che la sociologia tende a definire come un fenomeno culturale, legato a fattori socio-ambientali (così come nelle teorie della frustrazione, allorché l’individuo frustrato da particolari situazioni tende all’aggressività).
In una teoria dell’apprendimento sociale, l’aggressività viene quindi appresa all’interno dei gruppi di riferimento. In altri approcci scientifici, le cose sono un po’ diverse: alcuni studiosi, per esempio, cercano risposte alla domanda se vi sia un qualcosa di innato, in qualche modo, nei comportamenti aggressivi. Le discipline in qualche modo favorevoli ad una forma di innatismo nell’aggressività comprendo, per esempio, una buona parte dell’antropologia, dell’etologia e della psicanalisi.
L’etologo Konrad Lorenz, convinto assertore della propensione innata all’aggressività, racconta come nel mondo animale gli animali stessi tendano ad un’aggressività intra-specifica, cioè un’aggressività che sta all’interno della specie, e che si orienta verso l’esterno principalmente per motivi di nutrimento. In questa prospettiva, serve esclusivamente per stabilire dei rapporti di forza, e nel momento in cui uno dei contendenti si arrende, la guerra è finita. Lo stato di sottomissione e riconoscimento della superiorità altrui genera l’interruzione del momento aggressivo. Si tratta quindi di una aggressività sana, naturale, tesa allo sviluppo. Diverso il caso degli uomini, che invece sono in qualche modo protagonisti di una violenza “non naturale”, in qualche modo deviata.
qual è la principale differenza con il mondo animale?
L’uomo è diverso quando non manifesta l’aggressività in una sorta di corpo a corpo, quando non è più in grado di valutare, come invece accade nella lotta fra animali, il momento difensivo dell’altro. Nella teoria psicanalitica, Freud formula una teoria delle pulsioni, due in particolare: di vita e di morte, Eros e Thanatos, che reggono la vita dell’individuo. La pulsione di vita ci porta ad essere nella realtà, a creare immaginazione, a creare riproduzione, a creare vita. La pulsione di morte mira esattamente al contrario: alla distruzione psichica dell’uomo, ai momenti depressivi, al suicidio e, rivolta all’esterno, alla distruzione dell’altro. Considerata in forma collettiva, la percezione della rabbia sociale può invece perfino diventare un fenomeno positivo: dipende dalle circostanze specifiche e dalla modalità in cui viene espressa.
La rabbia sociale può portare a cambiamenti positivi quando è canalizzata in modo costruttivo attraverso il dialogo, la partecipazione democratica e il perseguimento di obiettivi comuni per il benessere della società. Per questo alcuni sociologi considerano la rabbia sociale come un catalizzatore per il cambiamento sociale e politico. Quando le persone si mobilitano contro ingiustizie e disuguaglianze, possono spingere per riforme e progressi significativi nella società. La rabbia sociale può portare all’attenzione pubblica su questioni importanti e stimolare il dibattito su cambiamenti necessari, in una sorta di espressione di democrazia partecipativa. In contesti democratici, la rabbia sociale può essere vista proprio come un’espressione legittima della partecipazione politica e civica.
Il diritto di protestare e manifestare è spesso considerato fondamentale per il funzionamento di una democrazia vibrante, consentendo alle persone di esprimere le proprie opinioni e rivendicare i propri diritti. In questa prospettiva, le manifestazioni di rabbia sociale possono contribuire a una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione su questioni sociali importanti. Quando le persone si mobilitano per protestare contro ingiustizie e discriminazioni, possono educare il pubblico, promuovere la solidarietà e incoraggiare azioni concrete per affrontare i problemi sottostanti. In situazioni in cui le istituzioni falliscono nel proteggere i diritti fondamentali o nel rispondere alle esigenze della popolazione, la rabbia sociale può allora essere vista come una risposta naturale e legittima.
La resistenza contro gli abusi di potere e la violazione dei diritti umani può essere intesa come un segno di cittadinanza attiva e impegno per la giustizia sociale. Da questo punto di vista, gli esempi di analisi sociologiche sono piuttosto fiorenti. Molti sociologi classici se ne sono occupati a vari livelli: Marx nei suoi scritti sulla teoria del conflitto e sulla critica al capitalismo, e nelle analisi della lotta di classe e delle disuguaglianze economiche, Durkheim nella sua attenzione sulla solidarietà sociale e sui cambiamenti nella struttura sociale, Weber con la sua analisi delle dinamiche di potere e delle istituzioni sociali, utile per comprendere come la rabbia sociale si sviluppi in risposta a percezioni di abuso di potere o disfunzione istituzionale.
E ancora, Georg Simmel che ha contribuito alla comprensione delle interazioni sociali e dei gruppi. La sua teoria del conflitto e della contraddizione sociale è certamente utile per esplorare le tensioni e le contraddizioni che portano alla rabbia sociale. Infine, considerato uno dei precursori del socialismo, Henri de Saint-Simon ha sottolineato la necessità di una riforma sociale per affrontare le disuguaglianze: il suo lavoro si collega direttamente all’analisi della rabbia sociale in contesti in cui le persone lottano contro le ingiustizie percepite. Ma gli esempi possono essere davvero tantissimi.
La sociologa statunitense Frances Fox Piven, ad esempio, ha studiato il ruolo delle proteste di massa nella storia degli Stati Uniti. Nei suoi scritti sostiene che le mobilitazioni di massa e la rabbia sociale possono essere uno strumento importante per spingere le istituzioni a rispondere alle esigenze e alle richieste della popolazione, evidenziando quindi il potenziale trasformativo delle proteste nel plasmare le politiche sociali.
Il suo collega Charles Tilly ha invece esaminato la relazione tra conflitto sociale e cambiamento istituzionale, sottolineando come la rabbia sociale e le proteste siano spesso catalizzatori per le trasformazioni sociali e politiche. Tilly ha evidenziato come i movimenti sociali possano influenzare la redistribuzione del potere e portare a cambiamenti positivi nella struttura sociale. Dal canto suo, anche Michael Lipsky, sociologo e studioso delle politiche pubbliche, ha esaminato il ruolo delle proteste e delle manifestazioni nella creazione di cambiamenti politici e sociali, convinto che la rabbia sociale può essere vista come una forma di “politica di strada” che spinge per l’attenzione e la risposta alle questioni sociali urgenti.
Non tutto il male viene per nuocere, verrebbe insomma voglia di pensare. Fra l’altro, la storia dell’umanità è costellata da moltissimi episodi che hanno visto il rovesciamento di governi e monarchie proprio a partire da mobilitazioni collettive che avevano alla base fenomeni assimilabili ad una espressione di rabbia sociale sfociata in fenomeni di aggressività collettiva. Ma dobbiamo sottolineare che se la rabbia genera aggressività, la rabbia non è l’aggressività. È certamente una sorta di preludio dell’aggressività ma non è tale. La rabbia è un insieme di emozioni e sentimenti, paragonabile probabilmente a una passione, che ha nella sua radice il patire. Un patire che sfocia pericolosamente, quindi, nell’aggressività laddove venga percepito come il subire passivamente qualcosa.
Ma la sociologia ci insegna che la cultura gioca un ruolo importantissimo, decisivo nei confronti dello sfociare della rabbia sociale in comportamenti aggressivi, assieme probabilmente ad un innato istinto che deriva dall’evoluzionismo. Questo rende ancora più urgente un bisogno di lavorare sull’educazione all’aggressività, sul rendere possibile una coesistenza – pacifica – fra l’istinto all’aggressività e una cultura della gestione dei conflitti che eviti risposte inadeguate. Perché se è vero che nel passato molti movimenti hanno portato a mutamenti sociali importanti, è altrettanto vero che forse è arrivato il momento di comprendere che se vogliamo davvero evolverci dal nostro passato di primati dobbiamo lavorare usando intelligenza e cooperazione. Senza alimentare fratture che portano solo a disperazione e disastri umanitari.
La qualità dell'informazione è un bene assoluto, che richiede impegno, dedizione, sacrificio. Il Quotidiano del Sud è il prodotto di questo tipo di lavoro corale che ci assorbe ogni giorno con il massimo di passione e di competenza possibili.
Abbiamo un bene prezioso che difendiamo ogni giorno e che ogni giorno voi potete verificare. Questo bene prezioso si chiama libertà. Abbiamo una bandiera che non intendiamo ammainare. Questa bandiera è quella di un Mezzogiorno mai supino che reclama i diritti calpestati ma conosce e adempie ai suoi doveri.
Contiamo su di voi per preservare questa voce libera che vuole essere la bandiera del Mezzogiorno. Che è la bandiera dell’Italia riunita.
ABBONATI AL QUOTIDIANO DEL SUD CLICCANDO QUI.
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA